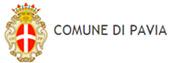Vita e morte nella cultura greca: e per noi?

Questo libro di Mauro Bonazzi, professore di Storia della filosofia antica presso l’Università di Utrecht e l’Università Statale di Milano, è un’indagine, una sorta di viaggio intellettuale, sul modo in cui la grande cultura greco-romana ha pensato la morte, e in relazione ad essa la vita. Si tratta di un testo che unisce a un’erudizione ammirevole un’eleganza, un garbo e un brio che ne fanno una lettura gradevole e istruttiva anche per i non addetti ai lavori. Implicita nella ricostruzione storica è una domanda esistenziale: le soluzioni date dalla classicità al problema del senso della vita, e quindi della morte, in che misura ci riguardano ancora? Per coincidenza il libro giunge al pubblico in un momento in cui la reclusione forzata indotta dal coronavirus avrà sicuramente costretto almeno qualcuno a porsi questo stesso tipo di problema: il che forse aiuterà nella lettura di un testo ricco di dettagli coloriti e interessanti. Ecco due esempi: l’indicazione del rapporto, nascosto ma decisivo, tra il pensiero di Freud e quello di Platone, mediato dal grande storico della filosofia greca Theodor Gomperz; la caratterizzazione dell’Etica Nicomachea di Aristotele come “una specie di romanzo giallo, con il filosofo nel ruolo di detective”. Non è naturalmente possibile seguire l’autore nei particolari del suo viaggio. Basterà qui individuare almeno la direzione di marcia e le tappe fondamentali.
Il punto di partenza è costituito da Omero. “Da una parte c’è la natura che ci circonda, immensa e indifferente alla nostra sorte – per i Greci educati da Omero il mondo non è fatto per noi e noi non siamo proprio al centro di nulla – e dall’altra il tentativo degli uomini di costruire qualcosa di umano, lasciando una traccia che non scompare” (p. 59). Per usare i termini greci, da una parte c’è thanatos, la morte, dall’altra eros, l’amore, il desiderio di vita: e la posta in palio è la felicità. La prima forza è espressa nel modo più chiaro nella dichiarazione di Glauco (Iliade, VI, vv. 145-149), “pochi versi, tra i più celebri del poema”, commenta Bonazzi: “Tidide magnanimo, perché mi domandi la stirpe?/ Come stirpi di foglie, così le stirpi degli uomini;/ le foglie, alcune ne getta il vento a terra, altre la selva/ fiorente le nutre al tempo della primavera;/ così le stirpi degli uomini: nasce l’una, l’altra dilegua” (p. 47). Dunque, la regola è il succedersi delle generazioni, la scomparsa dell’individuo. Ma, se questa regola vale per il complesso dei viventi, è possibile un’eccezione per alcuni esseri umani (che pure Omero non a caso chiamava “i mortali”, hoi thnetoi)? Questa eccezione, per gli eroi omerici, è costituita dalla fama (kleos). E ad essa allude Pindaro (V secolo a.C.) , nei bellissimi versi (95-97) dell’ottava Pitica, “scritta per celebrare … il vincitore dei giochi che si erano tenuti in onore di Apollo Pitio nel 446 a.C.” (p. 28):
Creature di un sol giorno [epameroi]: che cos’è mai qualcuno [tis]/ che è mai nessuno [ou tis]?/ Sogno di un’ombra/ è l’uomo. Ma quando la luce discenda da un dio/ fulgida splende la luce sugli uomini/ e dolce è la vita.
Tornando ad Omero, una digressione necessaria riguarda le pagine molto belle, che consiglio caldamente, in cui Bonazzi indica le due interpretazioni alternative del senso dell’Iliade, che si svilupparono tra le due guerre: quella dei nazisti e quella di alcuni studiosi di origine ebraica, il grande filologo Erich Auerbach e le due geniali filosofe Simone Weil e Rachel Bespaloff. Mentre i primi esaltavano l’Iliade come descrizione esemplare della lotta per la sopravvivenza, che domina nel mondo animale e deve dominare anche in quello umano - una lotta che finisce con il trionfo del più forte (e noi naturalmente sappiamo che cosa abbia voluto dire per l’Europa e il mondo questa ideologia criminale), Auerbach contrapponeva a questo modello di umanità animale “la profondità, umanità e ricchezza della Bibbia” (p. 42). Ma le due studiose andarono più in là: esse avevano capito che l’esaltazione della guerra ‘igiene del mondo’ non era il contenuto più profondo dei poemi omerici. “Il vero eroe, il vero argomento, il centro dell’Iliade è la forza. La forza adoperata dagli uomini, la forza che sottomette gli uomini, la forza davanti alla quale la carne degli uomini si ritrae. L’animo umano appare di continuo modificato dal suo rapporto con la forza: è travolto, accecato dalla forza di cui crede di disporre, piegato sotto il giogo della forza che subisce. […] Chi sa riconoscere che la forza, oggi come un tempo, è al centro di ogni storia umana, vi trova il più bello, il più puro degli specchi” (Simone Weil) (p. 43). La forza ”appare nell’Iliade contemporaneamente come la suprema realtà e la suprema illusione dell’esistenza” (Rachele Bespaloff) (p. 74). In altri termini, il sottofondo dell’Iliade non è l’esaltazione della forza, ma la compassione di fronte a quel gioco mortale che finisce con la sconfitta definitiva di tutti. “Il vero protagonista del poema … è … la morte” (p. 44).
Tornando al discorso sulle risposte greche alla mortalità, uno sviluppo ulteriore è data dal grande storico ateniese Tucidide (seconda metà del V secolo a.C.). Se negli eroi omerici la gloria era ciò che rendeva grande e in qualche modo immortale il singolo, Tucidide, nel discorso di Pericle in onore dei caduti nel primo anno della guerra del Peloponneso, trasforma la gloria del singolo in una gloria collettiva: la gloria della democrazia. “Se la democrazia è così importante è perché costituisce lo spazio comune in cui tutti possono partecipare, esprimendo il proprio punto di vista, cercando di far valere le proprie ragioni, realizzando la propria natura di animali politici. E’ uno sforzo condiviso, in altre parole, in cui le ragioni del singolo e quelle della collettività vengono idealmente a coincidere, creando un ‘individuo collettivo’” (p.62).
Ma veniamo all’altra forza che si oppone alla morte, e cioè all’amore. Qua il protagonista è senz’altro Platone. Accurate e piene di brio sono le riflessioni che Bonazzi conduce su alcuni splendidi dialoghi platonici dedicati alla descrizione e all’interpretazione dell’amore, in particolare il Simposio e il Fedro. Senza poterci soffermare sui dettagli, indichiamo la soluzione innovativa che Platone propone alla questione della morte: essa può essere superata, tramite l’amore, nella vita filosofica. Questo tema, sia pure con molte variazioni, verrà in sostanza ripreso dal grande discepolo di Platone, Aristotele. L’amore, spiega nel Simposio a Socrate una donna, la sacerdotessa Diotima, è la via privilegiata di accesso alla realtà più vera e più profonda, che non è quella della quotidianità ordinaria. “Guardiamo il mondo, le cose, noi stessi, e vediamo molteplicità e disordine, trasformazioni e decadenza. L’esercizio della filosofia, i gradini su cui salire, sono invece prima di tutto l’esperienza dell’unità: il movimento di ascesa è sempre un movimento verso l’unità che sta dietro e organizza la molteplicità. Tutto si tiene, e niente va perso: la visione finale, il premio che attende chi sia stato capace di compiere l’ascesa, non è una fuga in un’altra dimensione, ma la comprensione dell’unità che regge tutto, la capacità di accogliere la realtà nel suo ordine e nella sua bellezza. La realtà, così come si dispiega allo sguardo del filosofo, è di una bellezza abbacinante” (p. 96). Viene qui introdotto un tema venerabile e antico nella tradizione filosofica occidentale, quello di Dio (e infatti Bonazzi nota giustamente che la visione del tutto di cui parlavamo prima è, per esempio, anche quella di Spinoza, il filosofo panteista del XVII secolo). Ma il tema di Dio richiama necessariamente alla memoria il Cristianesimo, che è tanta parte della storia dell’Occidente. A simbolo di questa cultura, Bonazzi cita l’Ulisse di Dante, che è molto diverso da quello di Omero: il suo ‘folle volo’ culmina nel naufragio. Infatti, “il suo viaggio è fatto confidando nelle sole forze intellettuali, soltanto in queste: e qui sta la spiegazione del suo fallimento. Quello di Dante è invece un viaggio favorito dalla grazia divina, e per questo è un viaggio di salvezza, destinato al successo”. Bonazzi nota giustamente la profondità del senso di questa posizione di Dante, sull’insufficienza della sola ragione, richiamando un’affermazione del padre della bomba atomica, il fisico Robert Oppenheimer: “i fisici hanno conosciuto il peccato; e questa è una conoscenza che non potranno perdere” (p. 130). “La colpa, se si può definire tale”, commenta Bonazzi, “era stata la stessa [dell’Ulisse dantesco]: il desiderio di conoscenza, ancora una volta, aveva avuto la meglio su ogni preoccupazione etica” (ibidem).
A questo punto della sua argomentazione l’autore avrebbe potuto, per esempio, sviluppare tutto un discorso sulla bellezza unita alla grazia, da Raffaello a Bach a Dostoevskij. Invece il suo libro prende una svolta improvvisa: la citazione del celebre apologo di Nietzsche, da La gaia scienza, in cui il ‘folle uomo’ annuncia ‘la morte di Dio’. Questo testo è di meravigliosa fattura, e in genere Nietzsche è uno scrittore splendido, delicato e potente, la cui forza espressiva può essere paragonata a quella del suo gemello-nemico, il grande musicista Richard Wagner. E tuttavia ‘la morte di Dio’ vuol dire secondo Nietzsche la morte dell’uomo: è l’annuncio del superuomo (oltreuomo), colui che supera con un balzo non solo i pregiudizi morali correnti, ma la morale come insieme di norme vincolanti. Egli è libero, crea la sua morale, vive nell’innocenza del divenire. La compassione, l’amore predicati dalla morale cristiana (e non solo da essa) vengono ridotti da Nietzsche a una forma di sottile autodifesa dei deboli, dei mal riusciti, degli incapaci di lottare e di vincere nella dura battaglia per la vita. Ma allora, come conciliare il richiamo a Nietzsche con quello ai grandi pensatori del Novecento prima citati, radicati, in modo originalissimo, nella tradizione ebraica (e talvolta, come p. es. nel caso della Weil, dichiaratamente avversari di Nietzsche)? Ci pare una contraddizione interna. In ogni caso, questo riferimento alla ‘morte di Dio’ conduce Bonazzi all’ultima tappa del suo viaggio, e cioè ad Epicuro, di cui l’autore sottolinea la tesi fondamentale, che sovverte la precedente problematica greca: “la morte è nulla per noi”, perché quando ci siamo noi non c’è la morte e quando c’è la morte non ci siamo noi. Bonazzi fornisce rapidamente un ritratto accattivante non solo del pensiero di Epicuro ma anche della sua influenza su due dei più grandi poeti romani: Orazio, che ironicamente si definiva “un porco del gregge di Epicuro”, e Lucrezio, con le sue visioni del mondo nascostamente sofferte. Può sembrare dunque che il libro si concluda con un invito a vivere nascostamente, tra un ristretto gruppo di amici, praticando il calcolo dei piaceri. Ma non è così: l’autore è troppo lontano dalla classica compostezza di Epicuro, è troppo moderno (o post-moderno). La mortalità non si fa cancellare tanto facilmente. Ed ecco un rovesciamento inaspettato dell’epicureismo: “la morte … appare ora come ciò che dà valore alla nostra esistenza, che è così bella e preziosa, proprio perché fragile” (p. 250). Come dice un poeta statunitense del Novecento, Wallace Stevens: “La morte è madre della bellezza”. Forse il maggior fascino di questa ricerca di Bonazzi è proprio il suo carattere aperto, non finito, che sollecita la collaborazione del lettore.
w.m.
[Mauro Bonazzi, Creature di un sol giorno. I Greci e il mistero dell’esistenza, Einaudi, Torino 2020, pp. 156, euro 12,50]
Walter Minella - l'autore di questa recensione - ha diretto la rivista "Ulisse" e attualmente è il curatore della rubrica di recensioni della Biblioteca Bonetta di Pavia.