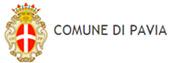Lizzie Doron, Cinecittà

Lizzie Doron è una importante scrittrice israeliana, nata a Tel Aviv nel 1953, discendente da una famiglia semidistrutta dalla shoah fuggita dall’Europa in Israele dopo la seconda guerra mondiale. In traduzione italiana la Giuntina ha già edito diversi suoi volumi, ultimo questo, “Cinecittà”. L’ho letto, ne sono rimasto molto colpito e ne consiglio la lettura a coloro che seguono queste schede sul sito della biblioteca Bonetta di Pavia. Il libro presenta una prima caratteristica anomala: finora è stato pubblicato in tedesco e in italiano, ma non ancora in ebraico. Pare dunque che un testo profondo e brillante del genere non sia ancora editorialmente proponibile tra gli ebrei e i palestinesi di Israele, perché affronta uno dei temi più spinosi: la possibile frequentazione, la possibile amicizia tra appartenenti alle due comunità. Questo, si desume dalla lettura del libro, è il tabù assoluto in un conflitto che dura ormai da decenni: l’amicizia, o anche solo la conoscenza simpatetica, con il nemico viene vissuta come l’equivalente del tradimento. E infatti in questo libro, che racconta lo sviluppo di una difficile ma autentica amicizia tra due nobili figure, Lizzie e Nadim, che rappresentano due punte nello sviluppo civile del loro popolo, l’autrice ha dovuto mascherare il personaggio (i personaggi?) di Nadim dichiarando, in una nota iniziale, che “Nadim è un personaggio fittizio, rappresenta i miei amici palestinesi che affidandomi le loro storie mi hanno aiutato a creare questo personaggio, a stendere questo libro”.
Il titolo della traduzione italiana (“Cinecittà”) è senz’altro fuorviante. Certo, c’è un blando legame con il contenuto del racconto, perché i due protagonisti si incontrano in un territorio neutro, a Roma, a Cinecittà, invitati da una militante pacifista (tra parentesi, osserviamo lo sguardo molto amichevole che i due protagonisti rivolgono alla nostra capitale e alla nostra cultura: siamo così abituati a scorgerne i difetti che un riconoscimento esterno non può che farci piacere). In realtà il titolo originale era in inglese (i due protagonisti parlano tra loro in inglese, e anche questo è un dettaglio significativo: nessuno dei due conosce la lingua dell’altro) e, nella sua ruvidezza, ben più significativo: “Who the Fuck Is Kafka”, “Chi cazzo è Kafka”. La traduttrice ha evidentemente ritenuto troppo diretto e volgare il titolo, a mio parere sbagliando, e ha preferito utilizzarne un altro. “Chi cazzo è Kafka?” allude a un episodio importante e altamente simbolico della vicenda: Lizzie e Nadim incontrano, su sollecitazione di Maria, una pacifista italiana, una rappresentante della comunità europea, che ascoltando il racconto di Nadim sulla vita quotidiana dei palestinesi nello stato d’Israele commenta più volte “kafkiano”. Questo commento, che per qualsiasi lettore occidentale è ovvio, risulta invece incomprensibile per il protagonista palestinese, che pure ci viene descritto come persona colta (oltre all’inglese e all’arabo conosce bene l’italiano perché ha studiato in Italia), brillante e simpatica. Ma egli evidentemente ignora uno dei caposaldi della cultura dell’Occidente nel Novecento. Ci verrebbe da dire “della cultura umana”, ma dobbiamo tener conto che questo universalismo passa attraverso la mediazione della cultura occidentale, più in particolare di quella europea, anzi di quella tedesca, anzi di quella di lingua tedesca di tradizione ebraica: una serie di mediazioni che per noi sono ovvie, ma non lo sono affatto per un palestinese, ancorché colto. Nella sua civiltà-mondo Kafka non esiste, come per noi non esistono figure e momenti centrali della sua esperienza del mondo. Si veda per esempio la descrizione del senso profondo dell’ attaccamento (suo e del popolo palestinese) alla religione islamica:
“Ramadan è il mese più importante della mia vita”. Non riusciva a concepire che non lo capissi. “Di tutto l’anno è l’unico mese in cui so chi sono. Non dimenticare che io non possiedo né uno Stato, né un inno, né una bandiera. Tutto ciò che mi resta è la religione, e la moschea è l’unico luogo che mi si offre, il luogo che mi dà un’identità, e la religione è ciò che posso tramandare ai miei figli. Solo attraverso la religione posso dimostrare a Mustafa e Nader [i suoi figli] chi sono io e chi sono loro. In quell’unico mese non mi faccio domande sulla mia vita, semplicemente vivo” (p. 185).
Innumerevoli sono gli episodi della scoperta, che l’autrice fa e di cui ci rende partecipi passo passo, delle condizioni vergognose di asservimento in cui sono tenuti i palestinesi nella vita quotidiana. Ma anche numerose sono le testimonianze delle sofferenze inflitte dai palestinesi agli israeliani: amiche dell’autrice vittime di attentati terroristi, il primo fidanzato morto in guerra… Eppure, nonostante tutto, Lizzie Doron non odia i palestinesi, pur detestando e temendo il terrorismo palestinese, e anche Nadim riesce a distinguere, un po’ per volta, la persona singola dall’apparato statale oppressivo, che strangola quotidianamente lui e il suo popolo. Non è possibile qui rievocare, nemmeno sommariamente, questi passaggi graduali di presa di consapevolezza. Si può fare solo una riflessione finale. In Occidente abbiamo capito, in linea di principio, la differenza tra Islam e fascismo islamista, tra una grande religione e la sua strumentalizzazione, ahimé molto diffusa e promossa da molti stati reazionari del Golfo, come ideologia politica. Non altrettanto mi pare sia avvenuto nei confronti dell’ebraismo: in linea di principio oggi tutti abbiamo presente la sua straordinaria grandezza come religione storico-mondiale, ma non abbiamo ancora trovato il termine critico adeguato per indicare le sue implicazione storico-politiche immediate. O meglio, ne esiste uno che però è del tutto fuorviante: sionismo. Il sionismo è la dottrina che afferma il diritto degli ebrei a una madrepatria, nei territori del loro più antico insediamento. Il sionismo di per sé non è la dottrina che afferma il diritto degli ebrei ad espellere o tenere in condizioni di apartheid un altro popolo. E questo ai più intelligenti e colti degli israeliani è palese. E’ esistito ed esiste tuttora un sionismo democratico, pacifista, socialista, oggi purtroppo minoritario, come riconoscono i grandi scrittori israeliani (Yehoshua, Oz e Grossman). Negli ultimi anni si è sempre più affermata nello Stato di Israele una variante di sionismo, che io giudico omologa al fascioslamismo: il sionismo dei coloni, che affermano il loro diritto di occupare, un pezzo per volta, la terra dei palestinesi. Per questo tipo di sionismo non si è trovato un termine giusto: ma questa lacuna manifesta la rimozione - degli occidentali e degli arabi - di un problema e di una sua possibile soluzione (due popoli e due stati). Questo libro straordinario ci indica una via pre-politica, psicologica, per accedere a una pacificazione. Il libro è dedicato “alla madre di Nadim e a tutte le madri che sono riuscite a indurre i propri figli a scegliere la pace e non la guerra”. Il brano in exergo riporta una citazione di Rabbi Chaim di Sanz:
“Quand’ero giovane in me ardeva la fiamma divina./ Credevo di poter rendere migliore il mondo intero./ Con il crescere dell’età si è spenta la fiamma dell’entusiasmo e mi dicevo: Non potrò più sanare tutto il mondo, non ne sono capace. Cercherò di rendere migliori i figli della mia città./ Col passar degli anni mi sono accorto di aver preteso troppo. Ho detto: Mi basta condurre al bene i miei familiari./ Ora, al tramonto dei miei giorni,non sogno più./ Mi resta un solo desiderio: che almeno mi riesca di migliorare me stesso”.
Un libro come questo tocca un nervo dolente della sensibilità contemporanea, per cui tante reazioni, anche di rifiuto o di rabbia, sono possibili. Quanto a me, dico soltanto “grazie Lizzie, grazie Nadim”: mi pare che, in fondo, sapere che esistono ancora persone come loro ci aiuti a cercare uno spiraglio di luce anche nelle tenebre più oscure.
w.m.
[Lizzie Doron, Cinecittà, traduzione di Paola Buscaglione Candela, Giuntina, Firenze, 2017]
Walter Minella - l'autore di questa recensione - ha insegnato storia e filosofia nei Licei. Tra le sue pubblicazioni: Il dibattito sul dispotismo orientale. Cina, Russia e società arcaiche (1991). Ha tradotto il breve saggio di Varlam Tichonovič Šalamov, il grande testimone dei Gulag, Tavola di moltiplicazione per giovani poeti (2012), ha curato la pubblicazione del libro postumo di Pietro Prini, Ventisei secoli nel mondo dei filosofi (2015) e ha scritto la monografia Pietro Prini (2016).