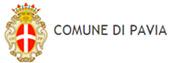Inattualità e grandezza di Laura Pariani

Forse un giorno gli storici della lingua procederanno a un accurato esame del linguaggio originale, personale, anzi unico, di Laura Pariani. E’ un italiano radicato nel dialetto lombardo, solo talvolta riprodotto sic et simpliciter ma che per lo più funge da elemento perturbatore e insieme arricchente rispetto alla norma linguistica, conducendoti a riflettere sulla parola italiana, a farla uscire dalla sua consuetudine logora, a vederla in una forma nuova e quasi, per così dire, ricreata, densa di risonanze e di sfumature. Questo italiano impregnato da tutti gli umori di una tradizione locale è spiazzante, difficile, talvolta anche per chi abbia conoscenza della radice linguistica lombarda - ma insieme affascinante, vivido e capace di attuare quell’effetto di straniamento che un’opera d’arte richiede.
L’uso espressionistico della lingua non è però soltanto un procedimento letterario, radicato nella linea lombarda della letteratura italiana che culmina in Gadda e in Testori. E’ anzitutto e soprattutto un segno della vicinanza dell’autrice ai suoi personaggi, cioè ai popolani della Valle del Ticino: gli umili, i poveri, gli oppressi. Allo stesso modo, in altri libri dell’autrice il riferimento al castigliano era funzionale alla rappresentazione del mondo degli emigrati italiani nell’Argentina tra fine dell’Ottocento e inizio del Novecento. Già da questo primo accenno risulteranno chiari alcuni motivi dell’ inattualità dell’opera della Pariani. La sua lingua è l’opposto della lingua corrente nel mercato editoriale italiano, una specie di omogeneizzato ‘televisivo’ insapore e scialbo, con forti influenze di un inglese imparaticcio e scolastico. Gli esempi si potrebbero moltiplicare. Limitiamoci alla considerazione che, se l’italiano viene banalizzato e, per così dire, ridotto da molti scrittori italiani contemporanei, il dialetto è quasi totalmente ignorato. Privilegiarlo come fonte di espressività e di testimonianze è decisamente ‘fuori moda’.
E poi, c’è la questione della semplicità, o meglio del semplicismo. In un paese, ma purtroppo dobbiamo dire in un mondo, abituato al ‘dominio contemporaneo del tweet semplificatore’, una lingua che invece imponga al lettore di soffermarsi sulle parole, per cosi dire di pesarle, è quanto meno complicata, difficile e già per questo sospetta: perché la complicazione è nemica del semplicismo facilone, che invece, come è noto, sarebbe ‘amico del popolo’. Il paradosso è che questa lingua della Pariani è veramente popolare, cioè è l’erede di una antica tradizione - il dialetto lombardo – che ormai sono rimasti in pochi (sempre meno) a conoscere e a parlare: pochissimi poi quelli che, oltre a conoscerlo perfettamente, conoscano altrettanto perfettamente la lingua e la cultura italiana, insieme a quella spagnola, come nel caso della Pariani.
Ma in questo romanzo non è in questione soltanto la lingua, che pure è così importante: è tutto un mondo di cultura popolare che viene recuperato dall’autrice. Perché il vero protagonista collettivo di questo romanzo storico, ambientato intorno alla metà del Seicento (tra il 1652 e il 1672) nella Valle del Ticino, nell’Alto Milanese, è il popolo lombardo, oppresso, poverissimo (anzi con i parametri di oggi diremmo miserabile), chiuso nelle sue ‘cassine’ o nei suoi paesini come in un mondo a parte, ignorante, per lo più analfabeta. Non c’è nella Pariani alcuna idealizzazione di questo popolo, ché anzi la povertà che l’autrice ritrae non è solo materiale ma anche psicologica e spirituale. L’autrice ne svela la dura ragione storica (l’oppressione, di classe e insieme spirituale, in una zona poco ospitale, la brughiera lombarda, funestata, intorno alla metà del Seicento, da guerre, pestilenze, incursioni e scorrerie) e ne rivela con pietà le radici di dolore e le forme di autodifesa: tra queste rientrano le tradizioni popolari più arcaiche, pagane. Perché questo popolo miserabile era anche portatore di una cultura antropologica autonoma, di cui erano rappresentanti le cosiddetto streghe, cioè le donne del popolo eredi di una sapienza antichissima (la conoscenza delle erbe, delle piante, degli animali) e di una visione magica del mondo, in cui elementi cristiani si fondevano con antichissime tradizioni popolari ‘pagane’. In questo sincretismo l’elemento formalmente dominante era il cristianesimo cattolico, che in questo romanzo viene rappresentato in uno dei suoi momenti più bassi, il periodo della Controriforma (il contrasto con la visione storica di Manzoni, il cui capolavoro è ambientato pressappoco nello stesso periodo e in una zona vicina, è implicito ed evidente). Come è noto, la Controriforma imponeva uno strettissimo controllo sulla coscienza dei villici, sostenuto dalla repressione della Santa Inquisizione e organicamente legato al potere della nobiltà terriera e dell’apparato statale. Alcune figure di preti (dal curato di campagna al cardinale) e di nobili (con il loro corteggio di servi e di funzionari statali) vengono disegnate in quest’opera con sarcasmo feroce. Eppure, nonostante tutto, qualcosa della radice più vera e autentica del cristianesimo risale fino ad alcuni elementi del popolo. Sarà un cristianesimo semplificato e naturalmente eretico, ma certo più vicino al messaggio originario di Gesù di quello proposto dal prete soprannominato nel romanzo Dicis-ma-non facis.
Il protagonista individuale del romanzo, il capobanda Bonaventura Mangiaterra costituisce l’espressione più autentica della ‘fame e sete di giustizia’, cioè di quella che potremmo chiamare la verità esistenziale del protagonista collettivo, il popolo. Per rappresentare il giovane eroe l’autrice ricorre allo stesso espediente narrativo – che però qui è anche un simbolo, oltre che un espediente – di Guimarães Rosa nel suo capolavoro Il grande sertão: non sveliamo l’enigma, lasciamo che siano i lettori a scoprirlo. ll controcanto di Bonaventura è la vecchia Pulvara, la ‘camminante’ che possiede il dono della parola che incanta e che, vent’anni dopo (1672), va alla ricerca pietosa dei particolari delle vicende a cui partecipò da giovane (il romanzo alterna capitoli ambientati nel 1652 ad altri ambientati nel 1672). Pulvara è anch’essa immersa nel mondo magico dei contadini: crede nelle coincidenze significative, pensa che gli avvenimenti possano essere pregni di valore numerico e che il senso dei numeri vada decifrato secondo le caselle del gioco di Santa Oca, viene guidata da una lupa nella ricerca del corpo di Bonaventura … C’è qui, forse, in questa sensibilità alle dimensioni della realtà che possiamo definire extrarazionali, una sintonia tra l’autrice e il suo personaggio. L’attenzione al cristianesimo, relativamente nuova rispetto al complesso della produzione della Pariani, era già emersa nel precedente libro della scrittrice, lo splendido romanzo distopico Di ferro e di acciaio. In quest’ultimo testo esiste, implicitamente, una dialettica - aperta - tra l’appassionata ricerca di giustizia del giovane Bonaventura e la smagata rassegnazione della vecchia Pulvara: “tutti trusciamo a sto mondo per nagotta … Noi siamo qui di passaggio. Chissà per dove” (p.268).
w.m.
[Laura PARIANI, Il gioco di Santa Oca, La nave di Teseo, Milano 2019, pp. 272, euro 18]
Walter Minella - l'autore di questa recensione - ha insegnato storia e filosofia nei Licei. Tra le sue pubblicazioni: Il dibattito sul dispotismo orientale. Cina, Russia e società arcaiche (1991). Ha tradotto il breve saggio di Varlam Tichonovič Šalamov, il grande testimone dei Gulag, Tavola di moltiplicazione per giovani poeti (2012), ha curato la pubblicazione del libro postumo di Pietro Prini, Ventisei secoli nel mondo dei filosofi (2015) e ha scritto la monografia Pietro Prini (2016).