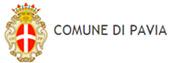Un romanzo fantastorico e il Doppio di Manzoni. Riflessioni sull’ambiguità della mente

A prima vista questo è un giallo storico, ambientato nella Milano di metà Ottocento, tra dimore nobiliari (il palazzo Beccaria a Brera), quartieri malfamati (il quartiere Bottonuto), chiese (splendida la descrizione di San Fedele), usi e costumi dei nobili e dei malviventi milanesi del tempo. Come tale si legge con curiosità e interesse: è un libro che, dopo che lo hai iniziato, non riesci a smettere (così almeno è capitato a me).
Come spiega l’autore in una specie di poscritto finale (Giustificazione e congedo) “mi sono persuaso che, se proprio volevo raccontare questa storia, non potevo fare altro che assoggettarmi allo stile e alle convenzioni di quei romanzi che Manzoni non volle scrivere e dai quali, nonostante tutto, noi lettori continuiamo a trarre un impareggiabile diletto. L’enfasi di Balzac, gli stratagemmi di Dickens, gli incredibili colpi di scena di Dumas père sono mescolati in questi capitoli, che hanno come elemento unificante il ricorso a una lingua intenzionalmente attardata su un versante settecentesco” (p. 233). Il quadro dunque si complica: abbiamo la testimonianza di un raffinato pastiche linguistico e narrativo che percorre sotterraneamente tutta la sapida invenzione di vicende interessanti e curiose.
Ma si deve subito aggiungere un terzo strato: questo è un romanzo fantastorico, cioè ambientato nella casa della madre di Manzoni, Giulia Beccaria, nell’anno della sua morte (1841) – ma una Giulia Beccaria d’invenzione che a suo tempo non avrebbe sposato Pietro Manzoni, il vecchio conte della profonda provincia lombarda, per legittimare il figlio avuto dalla relazione con Giovanni Verri ma, lo apprendiamo dallo svolgimento del romanzo, avrebbe abbandonato il neonato subito dopo la nascita. Giulia Beccaria quindi sarebbe rimasta signorina, marchesina, come è chiamata nel libro, fino alla vecchiaia estrema. Questo è il contesto, la situazione in cui è calata la storia. Un pezzo di bravura, un vero e proprio divertimento letterario è la descrizione dei maneggi di un baldo giovane francese, che però sostiene di essere in realtà un vecchio di settant’anni rimasto giovane d’aspetto grazie alle nuove cure che egli ora viene a proporre: maneggi, aspetto, promesse di ringiovanimento che suscitano la corsa al magico rimedio da parte delle dame della nobiltà milanese, infatuate per le terapie proposte (e per il giovane proponente). In alternativa alla medicina ufficiale il cosiddetto barone di Cerclefleury magnifica, come filtro dell’eterna giovinezza, il ‘magnetismo animale’, la terapia ‘energetica’ di Mesmer, che ricorda al lettore contemporaneo alcune delle più curiose e stravaganti cure alternative dei no vax attuali.
Una figura centrale del romanzo è un personaggio a prima vista secondario, Evaristo Tirinnanzi, un trovatello che nella casa della marchesina Giulia svolge il compito di contabile, anche se “restava il fatto che il Tirinnanzi non era un impiegato qualsiasi, ma come uno di famiglia, una sorta di figlioccio la cui opinione la marchesina era di certo abituata a tenere in grande considerazione” (p. 41). Costui, uomo del tutto modesto, presenta alcune caratteristiche esteriori – la timidezza, la balbuzie, la frequentazione di bische malfamate, il passo incerto, il coprirsi di vestiti anche quando fa molto caldo – che lo accomunano esteriormente ad Alessandro Manzoni (almeno al Manzoni della giovinezza, per quanto riguarda le bische) senza naturalmente averne il genio. Veniamo però a conoscenza di un dettaglio strano e curioso: ogni tanto sorge in lui una voce ignota, un Altro, che gli detta dei versi, delle frasi che egli trascrive senza capirle bene e che noi riconosciamo essere di Alessandro Manzoni.
Non sveleremo l’intreccio del romanzo, lasciamo che sia il lettore a farlo. Diciamo però che compare qui, in controluce, l’ultimo strato del libro: la meditazione su una figura grande e complessa – assai più di quanto solitamente si creda – come quella di Manzoni, uno scrittore particolarmente caro all’autore, che ne mette indirettamente in risalto gli aspetti più nascosti, ombrosi, notturni (come dice Mario Pomilio, citato in epigrafe all’ultimo capitolo: “[…] un uomo bisogna capirlo in quel che ha di notturno. In piena luce non siamo neppure un’ombra”). Emerge in sottofondo il tema del doppio, del Doppelgänger, dal titolo di una bellissima poesia di Heine musicata magnificamente da Schubert. In fondo, il doppio è una scoperta della seconda modernità, dal Sosia (Dvojnik, propriamente il Doppio) di Dostoevskij a Stevenson – Il dottor Jekill e mister Hyde – e Oscar Wilde - Il ritratto di Dorian Gray -: una figura concettuale che, intuita da Nietzsche e tematizzata da Freud, acquista una rilevanza centrale nella psicologia analitica di Jung, attraverso la categoria dell’Ombra.
E come dimenticare le scoperte delle scienze neurologiche? E’ noto il caso di Phineas Gage, l’operaio che subì un grave trauma cranico che gli cambiò completamente il carattere, come mostrato nel capolavoro di Damasio su L’errore di Cartesio. Al di là di questo caso estremo, ci si può chiedere, seguendo la suggestione del libro: ma quanto influiscono sul decorso di una vita le circostanze esterne, l’educazione, gli incontri, in positivo (per esempio un maestro) e in negativo (p. es. un amore sbagliato, una passione politica impropria)? Cosa sarebbe stato Manzoni se, invece di essere accolto nella casa del padre putativo, fosse stato abbandonato in un orfanotrofio? Qual è il rapporto tra lo sviluppo delle nostre potenzialità e le circostanze esterne che in qualche modo influiscono su di noi come, per usare un’immagine di Max Weber a proposito dello sviluppo delle civiltà, gli scambi ferroviari orientano la direzione che prenderà il movimento del treno? Sono domande legittime che, nella sua leggerezza narrativa, il romanzo propone.
Dice Zaccuri: “Il mio è, in definitiva, un componimento d’invenzione più che di storia. E’ il tentativo di rendere giustizia a Manzoni narrando una vita che non fu la sua ma che avrebbe potuto esserlo. Non intendo mancare di rispetto allo scrittore che più ammiro, né ergermi a giudice di sua madre Giulia, però mi rendo conto che qualcuno potrebbe accusarmi di confidenza eccessiva” (p.234). Di questa ‘confidenza’ – che non è eccessiva perché è il tentativo riuscito di mettere in evidenza narrativamente il doppio presente in ogni uomo, e particolarmente in ogni grande autore come Manzoni, tra la quotidianità scialba e l’Altro – suppongo sia testimonianza anche un primo libro di Alessandro Zaccuri, scrittore e giornalista di Avvenire, dedicato a Leopardi, Il signor figlio che, edito nel 2007, è di prossima ripubblicazione presso Marsilio. E chi, come me, non abbia avuto l’occasione di trovarlo in libreria sarà curioso di leggerlo, riprendendo così la visitazione contemporanea dei due grandissimi del nostro Ottocento.
Walter Minella
[Alessandro Zaccuri, Poco a me stesso, Marsilio, Venezia, 2022, euro 16]
Walter Minella - l'autore di questa recensione - ha diretto la rivista "Ulisse" e attualmente è il curatore della rubrica di recensioni della Biblioteca Bonetta di Pavia.